Il 70 e il 135 d.C. sono date estremamente importanti per la storia del popolo ebreo, perché la distruzione di Gerusalemme ad opera di Tito, poi imperatore nel 79 d.C., e successivamente la repressione dell’ultima rivolta ebraica in terra di Palestina, segnarono l’inizio della grande Diaspora, cioè della dispersione degli Ebrei nel resto del Medio Oriente e in Europa.
Questo spiega anche perché tracce della presenza di questo popolo si trovino anche in questa parte della Toscana ai confini con l’Umbria e il Lazio.
In particolare nei documenti d’archivio e nei libri ho trovato il ricordo di alcuni personaggi di origine ebraica legati alla storia della nostra zona e di un luogo, appena fuori di Chiusi, detto Poggio degli Ebrei, dove i loro morti “da tempo immemorabile” venivano sepolti.
Sette di loro hanno un nome e sono persone realmente vissute: si tratta di due medici, di due prestatori di denaro a pegno, di un poeta, di un cappellaio e infine di una badessa, ebrea convertita.
ebrea convertita.
L’ottavo personaggio, anonimo, appartiene alla leggenda, una leggenda cristiana legata al culto del Santo Anello della Madonna a Chiusi, una reliquia ritenuta miracolosa venerata prima nell’antica chiesa di S. Mustiola e poi nella cattedrale di Chiusi, dove rimase fino al 1473, quando fu rubata e portata a Perugia.
Questa in sintesi la leggenda: ai tempi dell’imperatore Ottone III, attorno all’anno Mille, l’anello giunge a Chiusi da Roma portatovi da un orafo, Ainerio, a cui era stato affidato da un mercante ebreo di pietre preziose, che gliene aveva rivelata l’origine; l’orafo però lo trascura, quasi dimenticandosene, fino a quando muore il suo figlio giovinetto, che durante il funerale risorge lo stretto tempo necessario per rimproverarlo e per invitarlo a far custodire col massimo onore la reliquia nella chiesa di S. Mustiola. Qui l’anello dà una prima dimostrazione delle sue qualità miracolose paralizzando il dito della contessa che aveva osato indossarlo; poi lo risana di fronte alle preghiere della nobildonna.
È evidente il ruolo fondamentale, provvidenziale, svolto dall’anonimo mercante ebreo, perché è lui ad affidare all’orafo chiusino l’anello trasmessogli come preziosa eredità dai suoi avi ed è lui che, nel donarglielo, gli rivela come esso sia lo stesso usato nel matrimonio fra Giuseppe e Maria, quella Maria “che voi cristiani chiamate Vergine” – gli dice – e alla cui stessa famiglia egli appartiene.
Nonostante nel medioevo, nel mondo occidentale, gli Ebrei abbiano spesso goduto di cattiva letteratura, questo mercante viene descritto in modo positivo, visto che rinuncia all’anello non per soldi e per spirito venale, ma per buon animo verso il cliente cristiano e la religione da lui professata, quasi si fosse già nel suo intimo convertito o desiderasse farlo.
Forse la chiave della luce benevola sotto la quale viene presentato il personaggio è proprio questo suo apparire “criptocristiano”, “cristiano nascosto”, tanto che la stessa figura assume tratti più aspri e negativi in una seconda versione della leggenda, scritta in volgare alla metà del Trecento (la prima, probabilmente più antica, è in latino).
In questo caso egli regala la reliquia solo per liberarsene, perché era divenuta l’oggetto dei suoi incubi notturni e non voleva rischiare per essa di allontanarsi dalla sua religione.
Va detto che proprio l’ “ostinazione” degli Ebrei a non convertirsi era sentita nel mondo medioevale cristiano come motivo di ostilità nei loro confronti, dal momento che appariva segno di “cattiveria” il loro rifiuto della nuova religione, il cui messaggio, per le comuni radici, essi avrebbero dovuto ben comprendere.
È possibile anche che dietro alla donazione della reliquia ci fosse il riflesso della legge che impediva agli Ebrei di detenere a pegno oggetti di culto cristiani ed altri che portassero il sigillo pubblico.
L’esistenza di tale norma ci fa comprendere meglio perché la Comunità di Sarteano il 3 settembre 1560 deliberò di farsi prestare da alcuni suoi facoltosi cittadini “una sbernia di damasco cremisi et una cotta di raso dorato” (una sorta di mantello da donna e una casacca o gonnella) e sedici “pezze di pàno lino”; era l’unico modo per procurarsi beni preziosi da impegnare a garanzia presso tale Benedetto Hebreo per ottenere un finanziamento di 90 fiorini da restituire in tre mesi.
Benedetto Hebreo (in un altro documento si legge: Hibrìo) sicuramente aveva un banco di pegni a Sarteano, non solo perché nel V volume delle Memorie del Comune rimangono testimonianze di più operazioni di prestito con lui protagonista, ma soprattutto perché è lo stesso Comune a imporgli con una deliberazione del 24 luglio 1561 il tasso d’interesse da applicare: il venti per cento.
Questa deliberazione è anche l’ultimo ricordo della presenza di un prestatore ebreo a Sarteano e, se si considera che la  prima era di poco anteriore al 30 luglio 1560, si deve desumere che tale presenza fu limitata nel tempo, così come breve fu il fiorire in quel periodo di numerosi altri banchi di credito ebraici nelle campagne attorno a Firenze, Arezzo e Siena.
prima era di poco anteriore al 30 luglio 1560, si deve desumere che tale presenza fu limitata nel tempo, così come breve fu il fiorire in quel periodo di numerosi altri banchi di credito ebraici nelle campagne attorno a Firenze, Arezzo e Siena.
Forse seguì la fine della Guerra di Siena nel 1559, quando anche Sarteano entrò nell’orbita dello stato fiorentino e quindi poté stabilire più facili relazioni con la roccaforte di Firenze in Val di Chiana, Montepulciano, dove viveva e operava un’importante comunità ebraica (44 persone nel 1570), che fra l’altro ci ha restituito un rarissimo registro del banco pegni scritto in ebraico risalente al 1409-1410.
La presenza cessò invece quasi sicuramente non oltre il 1571, quando furono creati i ghetti di Siena e di Firenze, destinati ad accogliere tutti gli ebrei dello Stato toscano, obbligati a trasferirvisi dopo che Cosimo I dei Medici, per divenire Granduca con l’appoggio del Papa Pio V, aveva rinnegato la sua precedente politica di tolleranza nei loro confronti.
Peraltro a Montepulciano, nonostante i divieti granducali, alcuni ebrei restarono fino al 1656, seppure impossibilitati sin dal 1570 ad esercitare qualsiasi attività di prestito, per la revoca di tutti i permessi.
In Toscana il clima di ostilità antiebraica si era manifestato apertamente già prima, nella seconda metà del ‘400 e agli inizi del ‘500, quando tuonarono contro l’usura soprattutto i Frati Francescani, fra cui San Bernardino da Siena ed il Beato Alberto da Sarteano, quasi parallelamente alla creazione dei primi Monti di Pietà, gestiti dal clero e da mercanti “di buona reputazione”.
Peraltro nello stesso periodo, alla corte di Lorenzo il Magnifico, attorno a Pico della Mirandola, scienziati e artisti ebrei contribuirono alla grande fioritura di studi che caratterizzò l’Umanesimo italiano.
In questo ambito si inserisce Abraham da Sarteano, che visse nella cerchia dei banchieri letterati di Firenze e Volterra e che attorno al 1491 partecipò a una gioiosa tenzone tra poeti ebrei “in lode e in biasimo della donna” con una lunga poesia satirica intitolata “Il misogino”.
Abbiamo ricordato una badessa, ebrea convertita.
Il suo nome era Donna Angela ed era badessa del Monastero di S. Stefano a Chiusi.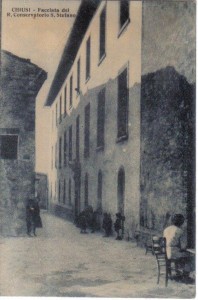
Probabilmente si era convertita al cristianesimo in età avanzata, quando già aveva un figlio, ed era entrata in convento portando in dote i suoi beni.
Evidentemente era ricca.
Nel gennaio 1569 i magistrati del Comune chiesero al vescovo di rimuoverla dalla carica. Ufficialmente la motivazione della richiesta era la cattiva gestione delle proprietà del monastero, ma la data è sospetta perché coincide con la nuova politica antiebraica della casata Medici; di lì a poco, nel giugno dello stesso anno, sarebbe giunto anche l’ordine sovrano che proibiva ai Chiusini di tenere nella loro città gli Ebrei.
Forse si voleva solo allontanarla e allontanare con lei il figlio e i nipoti, dato che per ottenere spontaneamente questo risultato la contropartita offerta era la restituzione di tutti i beni portati in dote al Monastero più un’ulteriore somma di 25 fiorini.
In fondo la città di Chiusi era abituata a convivere con gli Ebrei, come dimostra la presenza “da tempo immemorabile” (così si affermava nell’anno 1600) di un luogo destinato alla sepoltura dei loro morti (ma anche per piantarvi le forche) e la memoria specifica di due medici cerusici condotti (Maestro Salomone, nel 1496, e Magistro Moysy (Mosè) Aliucci di Montepulciano, nel 1462-63), di un prestatore di denaro nel 1508 (Ishael Ebreo) e, ancor prima, nel 1493, di statuti in 18 articoli pattuiti “con certi Ebrei” per disciplinare le attività di prestito dietro pegno.
Nel 1463, a Chiusi, il medico Mosè fu tra l’altro l’unico assieme al Comune a contribuire al finanziamento della Crociata di Papa Pio II (L. 200 la sua quota; L. 260 quella del Comune).
Come a Montepulciano un certo numero di Ebrei continuò a vivere in città anche dopo la creazione dei ghetti di Siena e Firenze. Lo dimostrano una supplica rivolta dal Comune al Granduca nel 1591 perché consenta a Prospero Ebreo, cappellaio, e alla sua famiglia di metter su casa e bottega dentro Chiusi; la risposta fu “Concedesi, purché non impresti”. Nel 1636 la richiesta fu analoga per altri due ebrei.
Le notizie raccolte sono sicuramente scarne ma due dati balzano subito all’attenzione: il numero limitato degli Ebrei presenti e il loro livello culturale generalmente elevato.
Cognizioni tecniche approfondite e un buon bagaglio di conoscenze erano del resto indispensabili perché essi potessero esercitare le sole attività che per legge erano loro consentite: alcuni mestieri manuali, di tipo artigianale (fabbro, sarto, muratore, tessitore, vasaio, …), certe occupazioni del settore terziario (osti, librai, scrivani, …), ma nessuna libera professione, salvo quelle di medico, prestatore di denaro, coniatore di monete e importatore di spezie.
Forse, però, è stato proprio il livello culturale sensibilmente superiore alla media del tempo, assieme alla fede religiosa, la forza (l’ “ostinazione” tanto contestatagli) che ha consentito a questo popolo di mantenere la propria identità per più di due millenni, a dispetto dei suoi numeri (una consistenza demografica limitata a famiglie e piccole comunità all’interno di grandi nazioni) e delle tremende persecuzioni di cui è stato vittima.
Sin qui ho parlato del popolo ebreo che non si confonde con gli altri e anche degli altri che nel tempo hanno voluto evitare di mescolarsi ad esso, tanto da rinchiuderlo letteralmente, nelle città, in un ghetto, un quartiere con tanto di cancelli che la notte venivano serrati.
Soprattutto ho parlato di presenze fisiche.
Ora vorrei affrontare il tema delle sopravvivenze culturali, delle tracce cioè che nella cultura di questi luoghi hanno lasciato tali presenze, numericamente forse limitate ma si direbbe costanti per secoli, se – come visto – un documento del 1600 (bando indirizzato dal Gonfaloniere e dai Priori di Chiusi al Vescovo, per l’affissione sulla porta della Cattedrale) attesta l’uso “per tempo immemorabile” di far seppellire i loro morti “in un certo poggio posto in corte di Chiusi contrada il Portone nomato Poggio del Ebrei”.
Alcune appartengono alla categoria dei luoghi comuni, fondati su pregiudizi la cui nascita sarebbe troppo comodo e antistorico attribuire alle Leggi razziali di Mussolini del 1938, pur se la propaganda all’epoca fu forte e capace di attecchire rapidamente nei modi di dire ancor prima che nei cuori.
È il caso dell’uso della parola “ebreo” in un certo nostro intercalare, non nel senso etnico suo proprio ma in quello dispregiativo di “avaro”, uso probabilmente radicatosi perché agli occhi del popolino assillato dai bisogni chi prestava denaro dietro pegno (l’ebreo) possedeva molto denaro e viveva miseramente, sfuggendogli che per quel prestatore il denaro non era una proprietà come la terra per il padrone, ma essenzialmente uno strumento di lavoro come per i nostri vecchi la zappa o “le bestie“; nelle sue orecchie non potevano inoltre non risuonare gli echi delle prediche del clero contro l’usura.
Si possono invece escludere ragioni sociali recenti, perché la storia moderna delle presenze ebraiche in Val di Chiana, quella cioè successiva all’unità d’Italia, rivela piuttosto, nei rapporti con la gente comune, momenti importanti di solidarietà e di condivisione di obiettivi.
Sono esemplari le storie di Marcella Levi Bianchini, ebrea sfuggita al rastrellamento del Ghetto di Roma dell’ottobre ’43, che a Chiusi trovò ospitalità e rifugio per mesi fino all’arrivo degli Alleati, e di Aldo Mieli, altro ebreo, figlio del ricco proprietario terriero della Foce, che, socialista e letterato, fu tra i principali organizzatori della protesta contadina del maggio 1902, a Chianciano, la prima in Toscana.
Al nome Mieli è legata anche la donazione di un’importante collezione di reperti etruschi in favore del Comune di Siena, ora conservata nel museo dell’Accademia dei Fisiocritici, segno che nel primo ventennio del secolo scorso anche i rapporti con le istituzioni pubbliche erano più che buoni.
Devo peraltro annotare una voce dissonante, che mi è stata riferita relativamente alla pretesa che “l’Ebreo padrone della Foce”, quindi presumibilmente lo stesso Aldo Mieli o suo padre, avrebbe avuto nei confronti delle donne che si recavano nella Grotta delle Pocce Lattaie per attingere l’acqua della polla che vi scaturiva, ritenuta sin dall’antichità “miracolosa” e in particolare capace di favorire la secrezione del latte nelle puerpere. Voleva essere pagato, in quanto proprietario del fondo.
Su di una voce non si possono costruire teorie ma la lettura più ragionevole dell’episodio, qualora gli si riconoscesse un fondamento di verità, potrebbe essere la seguente: da un lato le donne che sono fonte della notizia, arrabbiate contro quella che a loro appare, per pregiudizio antico, l’ “avidità dell’Ebreo”; dall’altra il padrone del luogo, intellettuale progressista, che richiede l’obolo assolutamente non per ingordigia ma per porre freno a quella che dall’alto della sua cultura ritiene una pratica superstiziosa e bigotta.
Tutto questo in un’epoca in cui nella vicina Chianciano lo sfruttamento delle acque minerali e termali era già un’attività imprenditoriale avviata.
Va da sé che un contributo illuminante potrebbe venire dalla lettura degli scritti e delle carte di Aldo Mieli e della sua famiglia.
Torniamo a un passato più remoto con una tradizione popolare che è invece segno delle comuni radici religiose: l’uso delle rose nei riti della Pentecoste, la Pentecoste cristiana e quella ebraica (Shavuot), che entrambe ricorrono tra maggio e giugno, cinquanta giorni dopo la Pasqua.
Quando parlo della Pasqua, anche in questo caso mi riferisco a una festa comune alle due religioni: la Pasqua di resurrezione dei Cristiani e la Pasqua ebraica (Pesach), che celebra il passaggio del Mar Rosso da parte del popolo d’Israele guidato da Mosè in fuga dall’Egitto.
La fonte delle notizie, per la parte cristiana, sono sempre gli archivi della Valdichiana, seppure l’usanza di far cadere dall’alto petali di rosa durante la messa della vigilia di Pentecoste appartenga più in generale alla tradizione medioevale romana ed abbia dato il nome alla festa, nota in passato come “Pasqua (Pascuccia) rosata” o “Pasqua rosa”, che poi è lo stesso nome ancora in uso presso gli ebrei di Roma per chiamare Shavuot, quando, forse per ricordare il profumo dei fiori presente al momento della promulgazione della Torà (la Legge) sul Monte Sinai, le sinagoghe ricevono un addobbo floreale, di rose in particolare.
A Chiusi c’era la consuetudine di adornare di rose il grande vaso di terracotta, o “conca”, che conteneva l’acqua che, dopo essere stata consacrata, veniva portata a casa dai fedeli insieme alle rose, in segno di benedizione.
Non presuppone invece necessariamente radici comuni o presenze locali l’esistenza nel vernacolo chiusino di fenomeni fonetici e vocaboli tipici del bagitto, il linguaggio parlato un tempo dagli ebrei livornesi: è il caso della trasformazione della “v” in “b” nella parola “voce”, pronunciata “boce” (da cui anche “bociare” e “Bociona”, il soprannome di una vecchia bidella), e di aggettivi come impipinito (pieno di sé, molto preso da un’emozione o convinzione) e gadollo (“bello gadollo” = robusto, pasciuto, dall’ebraico “gadol”, grande), che qui comunque rimangono nel limbo di un uso occasionale e quasi sempre caricaturale.
Tutt’al più contatti potrebbero essere avvenuti a Livorno: in tempi recenti, per i molti ferrovieri lì emigrati per ragioni di lavoro, o anche più in antico; nel 1630, ad esempio, Flaminio Dei, esponente della più antica nobiltà chiusina, fu nominato addetto militare di quel porto divenuto la “città senza ghetto”, sede privilegiata di una grande comunità ebraica costituitasi
per effetto dei bandi (ricordati nel loro insieme come “Le Livornine”) con cui fra il 1591 e il 1593, per assicurarne lo sviluppo e il popolamento, il granduca Ferdinando I garantì ai mercanti “ebrei, turchi e mori” piena libertà di stabilirvisi e di commerciare, assieme alla più completa libertà di culto e di organizzazione interna delle rispettive comunità.
Rovistando tra le pieghe della nostra cultura materiale potremmo trovare ulteriori elementi di consonanza e d’identità, si pensi al brustico e al tegamaccio, piatti di pesce tipici del Lago di Chiusi e dintorni, cucinati con lisca e squame così come prescrivono anche le rigide regole ebraiche; in questa caso, però, a spiegare la coincidenza c’è solo la presunzione della formazione di entrambe le tradizioni culinarie in contesti naturali e sociali simili, quelli dei pescatori delle acque interne della Val di Chiana e della valle del Giordano.
Voglio concludere con un mistero, o meglio con un toponimo della cui presenza al momento non è possibile dare una spiegazione plausibile: Sionne, pronunciato “Zionne”, con la “z” sorda, da mia madre e dai suoi familiari, che ci abitavano.
In questa località prossima a Querce al Pino, individuata da un’altura che fiancheggia a occidente l’autostrada, si ritrova il nome del colle a mezzogiorno di Gerusalemme su cui Davide fondò la rocca, Sion, divenuto poi sinonimo di Gerusalemme stessa e del popolo d’Israele.
È forse il “Poggio del Ebrei” di cui parla il documento del 1600?
Credo che sia da escludere, perché l’ubicazione più plausibile di quest’ultimo, che era detto “posto in corte di Chiusi contrada il Portone”, dovrebbe essere fuori Porta Lavinia, alle falde della collina dell’Arcisa, dov’è presente il vocabolo Portonaccio (cioè “Portone Vecchio”), già censito nel catasto trigonometrico di fine ‘700 dell’Archivio comunale di Chiusi (particella 623 del Popolo di S. Secondiano), che probabilmente deve il suo nome ai resti d’una porta della città, la stessa ricordata da Bartolomeo Macchioni nell’ultimo decennio del XVII secolo (“il Campo della Recisa unisce con quello di Piero, e solo è separato da una porta antica”).
Le ripe sabbiose della collina si prestano poi ad essere stato teatro di attività abusive di cava di rena, le stesse che il bando del 1600 voleva impedire minacciando “punizione espressa con pene temporali e schomunica”; sappiamo infine che proprio la località Portonaccio nel 1911 ha restituito un sepolcreto risalente agli anni iniziali dell’occupazione longobarda della città (fine VI sec. a.C.) e pertanto d’individui che probabilmente ancora non risultavano integrati nella comunità cristiana di Chiusi.
Facile dunque vedere in questo luogo anche quello destinato per tutto il medioevo a “sepelire ebrei”.







anche io desidero ringraziarla, Roberto, per l’interessantissimo articolo con notizie che non conoscevo. Bravo!
Grazie Roberto per questo interessantissimo saggio che è un bel modo per onorare il giorno della memoria.